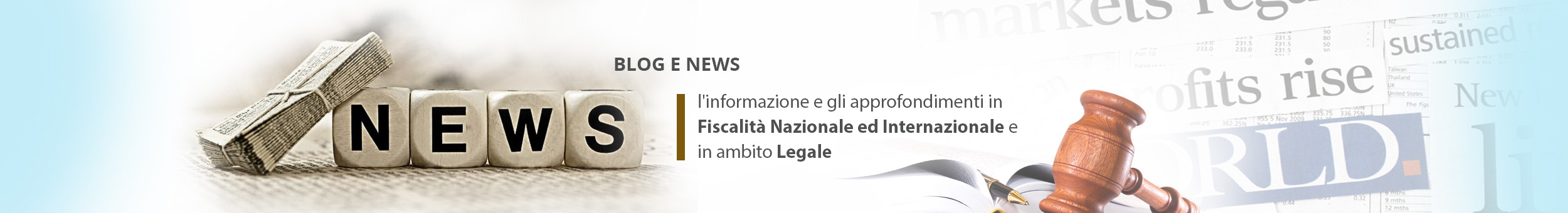L’evoluzione della nozione di “beneficiario effettivo” nel diritto tributario internazionale
A cura dell’Avv. Giulia Di Gregorio, partecipante All’Executive Master in Diritto Tributario e Contenzioso
L’abuso del diritto nella fiscalità internazionale riguarda tutte quelle pratiche volte a eludere le norme tributare vigenti tra gli Stati coinvolti. Comprende l’utilizzo di comportamenti giuridicamente leciti, in modo artificioso e strumentale, al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che altrimenti non sarebbe spettato. Questo modus operandi, pur formalmente conforme alle regole, è sostanzialmente in contrasto con la ratio della norma preposta.
Il fenomeno dell’abuso del diritto si manifesta diffusamente nell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni1 e nel loro uso distorto mediante le condotte di treaty shopping.
La nozione di treaty shopping2, infatti, trova la sua fonte nel diritto tributario internazionale e si riferisce alla pratica di utilizzare in modo improprio le Convenzioni contro le doppie imposizioni da parte di soggetti che, di fatto, non hanno diritto ai benefici previsti da tali trattati, ma cercano di accedervi attraverso strutture interposte.
Il meccanismo classico di treaty shopping prevede che un soggetto residente in uno Stato (che non ha un trattato favorevole con lo Stato della fonte del provento) crei o utilizzi una società interposta in un altro Stato che invece ha un trattato fiscale favorevole. In questo modo, cerca di ottenere una riduzione o esenzione della ritenuta alla fonte, aggirando di fatto lo “spirito” dell’accordo bilaterale.
In particolare, si tratta della creazione di società conduit, ossia entità giuridiche costituite in uno Stato esclusivamente al fine di rientrare nel relativo sistema impositivo e, in tal modo, beneficiare delle agevolazioni previste da una convenzione contro le doppie imposizioni, altrimenti non spettanti al soggetto effettivo.
 La giurisprudenza qualifica come società conduit quelle entità che si interpongono tra il soggetto erogante e il beneficiario finale, rivestendo il ruolo di percipienti meramente formali, la cui costituzione non risulta giustificata da valide ragioni economiche, se non dal perseguimento di un vantaggio fiscale3.
La giurisprudenza qualifica come società conduit quelle entità che si interpongono tra il soggetto erogante e il beneficiario finale, rivestendo il ruolo di percipienti meramente formali, la cui costituzione non risulta giustificata da valide ragioni economiche, se non dal perseguimento di un vantaggio fiscale3.
Per mitigare il fenomeno poc’anzi delineato, un ruolo sempre più centrale è assunto dalla cosiddetta “clausola del beneficiario effettivo” (beneficial ownership clause).
Tale concetto si contrappone alla figura del mero titolare formale del diritto, distinguendo tra il beneficiario nominale — colui che figura giuridicamente come titolare di un rapporto — ed il concreto beneficiario, ossia il soggetto che, al di là dell’intestazione formale, esercita un controllo sostanziale sul bene o sulla fonte di provento e ne trae concretamente i vantaggi economici.
L’introduzione di questa clausola ha l’obiettivo di superare la dicotomia tra titolarità giuridica e disponibilità economica, contrastando quelle strutture elusive in cui un soggetto, fisico o giuridico, viene interposto artificialmente per accedere indebitamente a regimi fiscali agevolati — in particolare, mediante la percezione di proventi in via meramente formale, al solo fine di ottenere una tassazione nulla o ridotta4.
Ripercorrendo la “nascita ed evoluzione” della nozione di beneficiario effettivo, vediamo come sia stata introdotta nell’ordinamento fiscale internazionale nel 1977, con la modifica degli artt. 10 (dividends), 11 (interest) e 12 (royalties) del Modello di Convenzione OCSE per evitare le doppie imposizioni5.
Questa concezione originaria di beneficiario effettivo, tuttavia, risultava difettosa e formulata in prevalenza in termini negativi, senza che il suo riconoscimento fosse legato a una valutazione sostanziale della posizione del percettore. La disciplina si limitava, infatti, a escludere dalla qualifica di beneficiario effettivo: a) agenti, fiduciari e altri intermediari, in quanto soggetti formalmente percettori dei redditi, ma privi della relativa titolarità sostanziale ai fini fiscali6; b) le conduit companies così come precedentemente analizzate.
Un rilevante avanzamento interpretativo si è avuto con la versione del Commentario OCSE del 2014, in cui si è chiarito che per qualificarsi come beneficiario effettivo non è sufficiente che il soggetto sia formalmente legittimato a percepire il reddito e assoggettabile ad imposta nello Stato di residenza, ma è altresì necessario che egli disponga del reddito in senso economico, ovvero ne abbia il controllo sostanziale.
Ulteriori precisazioni sono state introdotte nel Commentario all’art. 11 del Modello OCSE 2017, che afferma come il termine beneficial owner non debba essere interpretato in senso tecnico-restrittivo, ma alla luce del contesto normativo e degli obiettivi della Convenzione, quali il contrasto alla doppia imposizione, nonché la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale. In particolare, tale nozione è funzionale a chiarire il significato dell’espressione “paid to a resident” contenuta nel testo convenzionale8.
Nell’ambito della normativa unionale, la clausola del beneficiario effettivo è stata esplicitamente contemplata solo nella Direttiva 2003/49/CE, relativa al regime fiscale applicabile ai pagamenti transfrontalieri di interessi e royalties tra società consociate situate in diversi Stati membri9. L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva richiede infatti espressamente che il percettore del reddito sia il beneficiario effettivo, al fine di poter accedere all’esenzione dall’imposta alla fonte prevista dalla norma.
Diversamente, la Direttiva 2011/96/UE (nota come Direttiva Madre-Figlia)10, che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti tra società madri e figlie stabilite in Stati membri differenti, non menzionava espressamente la clausola del beneficiario effettivo; tuttavia, a partire dalla modifica introdotta con la Direttiva 2015/121/UE11, la normativa ha incorporato una clausola generale antiabuso (GAAR) all’art. 1, par. 212, con la quale si stabilisce che i benefici della direttiva non si applicano nei casi in cui operazioni o strutture abbiano come scopo principale, o tra gli scopi principali, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. Tale clausola, sebbene non coincida testualmente con quella del beneficiario effettivo, ne realizza in parte la funzione, mirando a neutralizzare strutture artificiose prive di sostanza economica, analogamente a quanto avviene nella disciplina convenzionale e nel Modello OCSE.
Sul piano nazionale, per rendere operativa la nozione di beneficiario effettivo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiama l’utilizzo di tre test, autonomi e disgiunti, che il soggetto interessato deve superare per provare la propria qualità di beneficiario ": i) il substantive business activity test, volto ad accertare se la società percettrice svolga un’attività economica reale e significativa; ii) il dominion test, finalizzato a verificare se la stessa abbia il potere di disporre liberamente degli interessi percepiti, ovvero se sia tenuta a trasferirli ad altro soggetto; iii) il business purpose test, che valuta le ragioni sottostanti all’interposizione della società nel flusso di reddito transfrontaliero, accertando se essa svolga un ruolo concreto nell’operazione finanziaria o se si limiti a fungere da semplice società schermo (conduit company)13.
 Un'ulteriore conferma dell'orientamento sostanzialistico ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità si rinviene nella recente sentenza n. 4427/2025 della Corte di Cassazione. In tale pronuncia, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dell’approccio look-through nell’ambito di un’operazione di finanziamento indiretto, ai fini dell’individuazione del beneficiario effettivo degli interessi passivi. Il caso riguardava una struttura articolata su tre livelli: una società italiana aveva ricevuto un finanziamento dalla propria controllante lussemburghese e, in esecuzione del contratto, aveva corrisposto i relativi interessi. Tuttavia, la società lussemburghese, una volta incassati gli interessi, li aveva integralmente retrocessi al proprio socio unico, un fondo comune di investimento, anch’esso stabilito in Lussemburgo.
Un'ulteriore conferma dell'orientamento sostanzialistico ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità si rinviene nella recente sentenza n. 4427/2025 della Corte di Cassazione. In tale pronuncia, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dell’approccio look-through nell’ambito di un’operazione di finanziamento indiretto, ai fini dell’individuazione del beneficiario effettivo degli interessi passivi. Il caso riguardava una struttura articolata su tre livelli: una società italiana aveva ricevuto un finanziamento dalla propria controllante lussemburghese e, in esecuzione del contratto, aveva corrisposto i relativi interessi. Tuttavia, la società lussemburghese, una volta incassati gli interessi, li aveva integralmente retrocessi al proprio socio unico, un fondo comune di investimento, anch’esso stabilito in Lussemburgo.
La società italiana ha quindi richiesto il rimborso delle ritenute operate sugli interessi, invocando l’esenzione prevista dall’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, introdotta solo successivamente al pagamento, ma comunque applicabile al caso di specie. L’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’istanza, sostenendo che il soggetto immediatamente percettore (la società lussemburghese) non possedesse i requisiti soggettivi richiesti dalla norma per fruire del beneficio fiscale, non essendo qualificabile come investitore istituzionale idoneo.
La Corte di Cassazione, con una motivazione particolarmente rilevante sul piano sistematico, ha respinto la tesi dell’Amministrazione, affermando che i requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’esenzione devono essere posseduti non dal mero percettore formale, bensì dal beneficiario effettivo degli interessi. In tal senso, l’applicazione del cd. approccio look-through risulta funzionale a far emergere la reale titolarità del reddito, soprattutto nelle operazioni di finanziamento infragruppo.
Questa evoluzione del criterio del beneficiario effettivo, da concetto meramente formale a criterio sostanziale, riflette l’esigenza di garantire un'applicazione autentica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in linea con i principi di equità fiscale e trasparenza.
L’interpretazione giurisprudenziale e l’armonizzazione normativa a europea e internazionale dimostrano come il diritto tributario stia gradualmente abbandonando una visione formalistica, per abbracciare un approccio sostanzialistico, volto a colpire le strutture artificiose e a valorizzare l’effettiva e reale intenzione dell’operazione economica.
In questo contesto, il ruolo della giurisprudenza e delle autorità fiscali sarà sempre più centrale nel bilanciare l’esigenza di contrastare l’elusione fiscale con quella di garantire certezza del diritto e tutela degli investimenti transnazionali.
- “Studio CMNP, Sistema Frizzera – Parte Generale: Principi generali. Principio della doppia imposizione, Il Sole 24 Ore S.p.A., ultimo aggiornamento 10 aprile 2025: “la doppia imposizione si verifica quando un contribuente residente in uno Stato produce reddito in un altro Stato. Il contribuente, in questo caso, si trova ad essere assoggettato sia a tassazione nello Stato ove ha percepito il reddito (c.d. «Stato della fonte»), sia nello Stato ove risiede (c.d. «Stato della residenza»). Questi due principi di tassazione applicati ad uno stesso reddito generano quella che in ambito fiscale viene chiamata doppia imposizione internazionale”.
- Garbarino, C. 2019, Diritto tributario convenzionale, Giappichelli.
- Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 26 febbraio 2019, cause riunite C-116/16 e C-117/16, T Danmark e Y Denmark Aps, in cui si afferma che l'interposizione di società prive di sostanza economica, create unicamente per accedere ai benefici convenzionali, costituisce abuso del diritto. Sul piano nazionale Cfr. Cass., 9 settembre 2022, n. 26290; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3380.
- V. S. Marinoni, Il “beneficiario effettivo” nella fiscalità internazionale ed europea. L’evoluzione della clausola tra soggettività, imputazione del reddito e abuso del diritto, Tesi di dottorato, XXXV ciclo (a.a. 2022/2023), Università degli Studi di Brescia
- R. Vasi, Clausola del beneficiario effettivo e rapporto con l’abuso del diritto tra conferme e novità alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione (nota a), in Tax News – Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 16 gennaio 2024, Giappichelli.
- OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version, OECD Publishing, 2014, Commentario all’art. 10, par. 12.1.
- OECD, Model Tax Convention, cit., Commentario all’art. 10, par. 12.4 e 12.5.
- OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version, OECD Publishing, 2017, Commentario all’art. 11, par. 10.1–10.4.
- Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa a un regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi, in GUUE L 157/49 del 26.6.2003.
- Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile, in materia di imposte sui redditi, alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in GUUE L 345/8 del 29.12.2011.
- Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2011/96/UE relativamente alla clausola contro le pratiche abusive, in GUUE L 21/1 del 28.1.2015.
- Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. VI, 3 aprile 2025, causa C‑228/24, Nordcurrent. “dai considerando 4 e 5 della direttiva 2015/121, la quale ha inserito, nella direttiva 2011/96, la disposizione antiabuso da allora contenuta nell’articolo 1, paragrafi 2 e 3 di quest’ultima, risulta che tale disposizione è molto utile, in particolare alla luce della diversità dei regimi fiscali nazionali, per evitare qualsiasi uso improprio di quest’ultima direttiva. Occorre considerare che, sia alla luce della sua collocazione, vale a dire all’interno del primo articolo della direttiva 2011/96, sia dell’obiettivo così espresso, detta norma riveste un carattere trasversale, il che depone a favore di un’interpretazione che consente la sua applicazione indipendentemente dalle circostanze in cui si verificano abusi”.
- Cfr. Cass., sez. trib., 14 ottobre 2024, n. 26681 e Cass., 28 febbraio 2023, n.6005.
Tags: BlogLegal